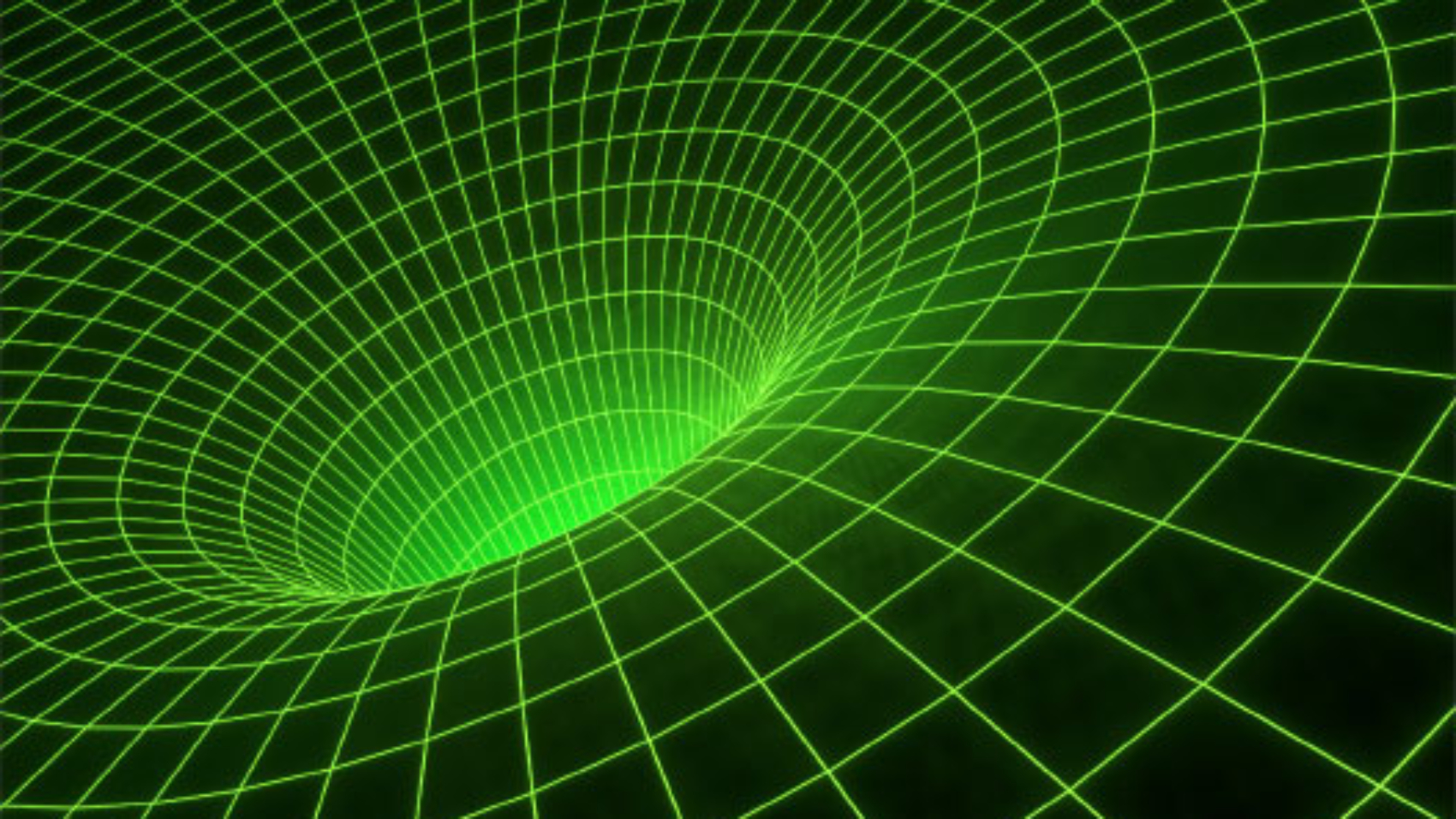di Massimiliano Ferrara e Bruno Antonio Pansera
All’interno del sistema finanziario globale si stanno susseguendo una molteplicità di mutamenti con ritmo incalzante. Una delle realtà che si sta sviluppando in maniera sempre più crescente, catalizzando l’attenzione di un numero sempre maggiore di operatori economici, è la finanza sostenibile. In poco tempo, essa si è trasformata da fenomeno di nicchia a fenomeno di massa, un mainstream con nuove prospettive evolutive.
Nell’ultimo periodo, il terreno fertile per affermare in modo definitivo questa tendenza è stato rappresentato dalla pandemia di COVID-19. La crisi che si è venuta a creare ha imposto ad aziende e organizzazioni di riprogettare il proprio modo di fare business, spingendole ad avviare una riflessione seria e quanto mai concreta sul concetto di sostenibilità.
La finanza si è immediatamente conformata a ciò, accelerando lo sviluppo degli Investimenti Socialmente Responsabili, ad esempio mediante l’acquisizione di quote di fondi comuni di investimento sostenibili e responsabili, con specifico riferimento alla loro performance. Questi strumenti finanziari si pongono come obiettivo quello di creare per i risparmiatori opportunità di rendimento in un’ottica di medio-lungo periodo, premiando imprese e Stati attenti alle tematiche ambientali, sociali e di governance d’impresa.
L’intento è quello di trattare in maniera più approfondita il tema dell’Investimento Socialmente Responsabile attraverso la descrizione dei differenti approcci che caratterizzano la finanza sostenibile ed approfondendo una particolare strategia di investimento sostenibile, in rapida espansione, che è quella dell’impact investing, attraverso cui l’investitore, oltre ad ottenere un rendimento finanziario, ha il forte interesse a generare un impatto sociale ed ambientale positivo, concreto e misurabile. Fondamentale è anche precisare il concetto di rating di sostenibilità che certifica la solidità di un’impresa o di un fondo comune d’investimento dal punto di vista degli aspetti ambientali, sociali e di governo societario.
Verso una economia sostenibile
Il termine sostenibilità, in ambito scientifico, è in costante espansione: il numero di definizioni e di modelli operativi cresce di pari passo con il rilievo che la sostenibilità assume nella vita quotidiana.
Come asserisce Enrico Giovannini, portavoce dell’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), nel suo recente libro L’utopia sostenibile:
“Abbiamo ormai un’evidenza scientifica consolidata dell’insostenibilità, sul piano non solo ambientale, ma anche su quello economico e sociale, del modello di sviluppo che abbiamo seguito nel corso degli ultimi due secoli.”
L’Autore sostiene che i diversi fenomeni naturali e sociali che si sono manifestati negli ultimi decenni costituiscono un segnale evidente dell’instabilità del sistema socioeconomico attuale (si pensi al cambiamento climatico, alle migrazioni globali o all’aumento delle disuguaglianze) e la combinazione di questi shock di natura economica, sociale e ambientale richiederà nel prossimo futuro un radicale cambiamento del modo in cui analizzare e affrontare i problemi globali.
È, dunque, evidente che è necessario e non più procrastinabile un cambio di rotta nella direzione dello sviluppo sostenibile, la cui prima e più nota definizione è contenuta nel “Rapporto Brundtland” (conosciuto anche come Our Common Future), documento elaborato nel 1987 dalla Commissione Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo (World Commission on Environment and Development, WCED) in cui si afferma:
“Lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri”.
In sostanza, la sostenibilità ha come obiettivo quello di imporsi su un’economia lineare che punta al profitto senza tener conto dei danni che tale modello comporta per l’ambiente e di conseguenza per le generazioni future. Lo sfruttamento non razionale delle risorse, anche se giovevole, non può essere sostenuto indefinitamente e quindi il passaggio ad un’economia sostenibile è necessario per consentire la sopravvivenza del genere umano.
Sono tre i pilastri sui quali si fonda e si dirama la sostenibilità: economico, ambientale e sociale.
La sostenibilità economica consiste nella capacità di un sistema economico di dare vita ad una crescita stabile e continua degli indicatori economici. In questa dimensione, il principio cui fare riferimento è quello di contribuire allo sviluppo della società riducendone costi e rischi, migliorando la qualità di prodotti e servizi, senza aumentare, o preferibilmente riducendo, le possibili conseguenze negative.
La sostenibilità ambientale si concentra su un utilizzo delle risorse ambientali che rispetti i vincoli posti dalla capacità di rigenerazione e di assorbimento da parte dell’ecosistema.
Infine, la sostenibilità sociale pone l’attenzione sulla necessità di raggiungere un miglioramento delle condizioni di vita attraverso un maggiore accesso ai servizi sanitari, educativi, sociali e al lavoro, ma anche attraverso il riconoscimento e la valorizzazione del pluralismo culturale e delle tradizioni locali, nonché sulla necessità di un sostanziale cambiamento nello stile di vita dei consumatori, promuovendo comportamenti sociali e istituzionali sostenibili.
Il perseguimento di uno sviluppo sostenibile richiede un approccio integrato su tutte e tre queste dimensioni. Occorrono in aggiunta una presa di coscienza e il contributo concreto, in termini di scelte e iniziative, da parte di tutti i soggetti del sistema socioeconomico, a partire dagli Stati e dalle istituzioni in genere, le forze politiche, i mercati finanziari, le realtà aziendali, e via dicendo fino alle famiglie e al singolo cittadino.
In armonia con questa impostazione, che chiama in causa una molteplicità di attori, la sostenibilità può essere analizzata da diverse prospettive: quella politica, quella delle scienze ingegneristiche-ambientali, quella sociologica, quella macroeconomica, quella economico-aziendale.
Esaminando il concetto di sostenibilità partendo da quest’ultimo punto di vista è fondamentale porre l’attenzione su concetti quali ‘Responsabilità Sociale d’Impresa’ e ‘Investimenti Socialmente Responsabili’.
Corporate Social Responsibility
La Corporate Social Responsibility, CSR (Responsabilità Sociale d’Impresa, RSI) è, in senso generale, quella pratica che consiste nell’adozione volontaria di una politica aziendale che sappia armonizzare gli obiettivi economici con quelli sociali e ambientali del territorio di riferimento, in un’ottica di sostenibilità, ovvero nell’intento di preservare il patrimonio ambientale e sociale per le generazioni attuali e per quelle future. La CSR, nel concreto, riguarda quindi non solo la qualità, l’affidabilità e la sicurezza del prodotto, ma anche la salvaguardia dell’ambiente e della salute, il risparmio energetico, la correttezza dell’informazione pubblicitaria, ecc.
In tal senso, la CSR dà rilievo alla componente etica nell’attività economica, in quanto considera l’impresa come un soggetto moralmente responsabile che, mediante molteplici iniziative mirate e consapevoli, rappresenta una sorta di garante nei confronti di alcuni stakeholder, tra i quali gli azionisti, i dipendenti, i clienti, i fornitori, la comunità esterna con cui l’organizzazione interagisce e l’ambiente in cui viviamo.
Il concetto di Responsabilità Sociale d’Impresa, nato intorno alla metà del 1900 negli Stati Uniti d’America sulla base dell’idea che l’impresa non potesse mirare solo al profitto, avendo invece la responsabilità di impegnarsi anche per il contesto sociale in cui opera, si presta ancora oggi ad interpretazioni diverse, non esistendo una definizione univoca ed universalmente accettata e condivisa.
Il contributo pioneristico, a cui si è soliti far risalire l’origine del concetto in esame, è quello di Bowen, il padre della CSR: Social responsibilities of the businessman del 1953. Come si evince dallo stesso titolo, però, si tratta di un lavoro centrato sulla sola responsabilità sociale dei businessmen; solo più tardi, infatti, si inizierà a parlare in letteratura di Responsabilità Sociale dell’Impresa.
Secondo Bowen: “La CSR fa riferimento agli obblighi degli uomini di affari di perseguire quelle politiche, prendere quelle decisioni, o seguire quelle linee di azione auspicabili in termini di obiettivi e valori della nostra società”.
Quindi, gli uomini d’affari, per Bowen, non possiedono soltanto obblighi economici, come l’ottenimento di profitto, la crescita produttiva o la distribuzione di beni, ma anche sociali, incidendo in modo diretto anche sul contesto ambientale.
Se in un primo momento sono soltanto i manager ad essere considerati titolari di tali obblighi ‘morali’, nel giro di un ventennio tale titolarità viene estesa alla stessa impresa ed è infatti tra gli anni Sessanta e Settanta che si comincia ad affermare propriamente la locuzione Corporate Social Responsibility.
Verso la fine degli anni Settanta, particolarmente illuminante, perché fondamento dei successivi approfondimenti sul tema, è il pensiero di A. B. Carroll che definisce la CSR come l’insieme di diverse responsabilità, descrivibile attraverso una piramide composta da quattro livelli: economico, legale, etico e filantropico.
Alla base della piramide è collocata la responsabilità economica, per sottolineare l’importanza che la sfera economica esercita sulle altre, producendo beni e generando profitti. Il livello successivo riguarda la responsabilità legale, che si identifica nel rispetto delle leggi e delle norme giuridiche da parte dell’impresa. Il terzo livello identifica la responsabilità etica, ossia i comportamenti e le norme, non codificati in leggi, che le imprese devono attuare e/o rispettare per soddisfare la società. Il vertice della piramide è rappresentato dalla responsabilità filantropica, identificabile con attività volontarie compiute dall’impresa a favore della società: essa comprende tutte le azioni che migliorano la qualità della vita ed accrescono il benessere della comunità.
Caratteristica fondamentale di questo modello è la fluidità: un’impresa che vuole essere socialmente responsabile deve attuare le quattro responsabilità in modo complementare e simultaneo.
Tra le linee di pensiero più discusse in tale ambito vi è quella del premio Nobel per l’economia nel 1976 nonché fondatore della dottrina monetarista, Milton Friedman. Nel suo famosissimo articolo The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, pubblicato nel 1970 dal New York Times, egli asserisce che le imprese devono focalizzarsi solo sul produrre profitto da distribuire sotto forma di dividendo agli azionisti. In altre parole, Friedman sostiene che l’unica responsabilità delle imprese è quella di utilizzare le proprie risorse in modo da aumentare i profitti e di conseguenza massimizzare il reddito dei conferenti di capitale di rischio (proprietari/azionisti), rispettando le leggi e le regole del contesto in cui esse operano, senza ricorrere a imbrogli o frodi.
In contrasto con questa posizione vi è la teoria degli stakeholder elaborata da Robert Edward Freeman e contenuta nella pubblicazione del 1984: Strategic Management: A Stakeholder Approach. Tale teoria mette al centro non solo i conferenti di capitale di rischio, ma anche tutti gli altri soggetti che influenzano o sono influenzati dall’attività dell’azienda, i cosiddetti stakeholder (i lavoratori, i fornitori, i clienti, le comunità locali). In particolare, Freeman sostiene che l’obiettivo dell’impresa è quello di soddisfare tutti i portatori di interesse e non solo i proprietari/azionisti e per fare ciò è necessario adottare iniziative su base volontaria che vadano oltre quelle obbligatorie per legge (attenzione per l’ambiente, miglioramento dei luoghi di lavoro e dell’atmosfera lavorativa, potenziamento della ricerca e dell’innovazione, miglioramento dei rapporti con le comunità locali etc.).
È proprio sulla base di tale teoria che si sono innestate ulteriori e sempre più approfondite analisi sull’argomento.
Socially Responsible Investment e fattori ESG
Socially Responsible Investment (da cui l’acronimo SRI) è un’espressione generale con cui si intende qualsiasi tipo di processo di investimento che armonizzi gli obiettivi finanziari di un investitore con l’attenzione alle questioni ambientali, sociali e di governo societario. Queste tre dimensioni rappresentano gli ambiti attraverso cui un’impresa contribuisce alla sostenibilità dello sviluppo, proprio e della comunità in cui opera.
Nella funzione obiettivo dell’investitore socialmente responsabile compaiono dunque due insiemi di argomenti, quelli propriamente economico-finanziari (responsabilità, negoziabilità, sicurezza) e quelli attinenti alle questioni ambientali, sociali e di governo societario, la cosiddetta triade ESG.
ESG è l’acronimo di Environmental, Social and Governance e si riferisce a tre fattori centrali nella misurazione della sostenibilità di un investimento:
• Criteri Ambientali: riguardano l’impatto diretto o indiretto dell’attività aziendale sull’ambiente (emissioni di gas a effetto serra, efficienza energetica, prevenzione degli incidenti industriali, gestione delle risorse idriche, gestione dei rifiuti ecc.).
• Criteri Sociali: riguardano l’impatto dell’attività aziendale sui suoi dipendenti, clienti, fornitori e sulla società civile in generale in riferimento a valori universali (diritti umani, norme internazionali del lavoro, lotta alla corruzione ecc.).
• Governance d’impresa: riguarda il modo in cui un’azienda è diretta, amministrata e controllata e, in particolare, le relazioni con i suoi azionisti, il suo consiglio d’amministrazione e la sua direzione.
Questo approccio deriva dal concetto di Triple Bottom Line, noto anche come “Persone, Pianeta e Profitti” (PPP), introdotto negli anni Novanta dallo scrittore, consulente aziendale e imprenditore John Elkington, secondo cui le aziende non dovrebbero concentrarsi solo sui profitti ma su ciascuna delle tre “P”.
Nel 2006, le Nazioni Unite lanciano i cosiddetti Principles for Responsible Investment (o PRI) con l’intento di favorire la diffusione dell’investimento sostenibile e responsabile tra gli investitori istituzionali.
L’adesione ai PRI comporta il rispetto e l’applicazione dei seguenti principi:
• incorporare parametri ambientali, sociali e di governance (ESG) nell’analisi finanziaria e nei processi di decisione riguardanti gli investimenti;
• essere azionisti attivi e incorporare parametri ESG nelle politiche e pratiche di azionariato;
• esigere la rendicontazione su parametri ESG da parte delle aziende oggetto di investimento;
• promuovere l’accettazione e implementazione dei Principi nell’industria finanziaria;
• collaborare per migliorare l’applicazione dei Principi;
• rendicontare periodicamente sulle attività e progressi compiuti nell’applicazione dei Principi.
I Principi ad oggi sono stati sottoscritti da più di 1200 firmatari tra investitori istituzionali, società di gestione del risparmio e fornitori di servizi.
Più di recente, per poter meglio guidare l’impegno verso il raggiungimento di un pianeta più sostenibile, nel settembre 2015 le Nazioni Unite hanno formulato 17 obiettivi, i cosiddetti Sustainable Development Goals (SDGs), a loro volta articolati in 169 target. Si tratta della cosiddetta Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, così chiamata in quanto i 193 Paesi delle Nazioni Unite che la hanno sottoscritta si sono impegnati a raggiungere gli obiettivi da essa definiti entro il 2030.
Gli SDGs sono ufficialmente entrati in vigore il 1° gennaio 2016 e, sebbene non siano legalmente vincolanti, rappresentano una fonte di ispirazione per i programmi e le politiche pubbliche di tutti i Paesi, a prescindere dal livello di sviluppo.
In ambito prettamente finanziario, gli SDGs sono un punto di riferimento per gli investitori SRI: essi, infatti, permettono ex-ante di individuare e selezionare i titoli, i progetti o i prodotti che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, ed ex-post di misurare gli impatti negativi e/o positivi prodotti, fornendo preziose indicazioni su come orientare le scelte future.
Nel 2020 il mondo ha assistito alla pandemia da COVID-19, un’epidemia, ancora in corso, diffusa a livello globale che ha portato a conseguenze sanitarie, sociali ed economiche disastrose. Il COVID-19 ha aumentato l’importanza del modo in cui le aziende operano e ha accelerato la crescente rilevanza delle tematiche ESG per gli investitori.
La gestione aziendale di temi quali i diritti umani, il benessere dei dipendenti e le relazioni con la comunità sono sotto esame, poiché le questioni che in passato sono state considerate lussi (ad esempio modelli di lavoro flessibili) sono diventate meccanismi critici di continuità aziendale nel blocco pandemico. Le azioni delle aziende potrebbero avere un impatto duraturo sulla loro reputazione e sulle relazioni future con clienti, fornitori e autorità di regolamentazione. Gli investitori stanno usando la loro influenza per guidare i cambiamenti comportamentali, e l’impegno degli azionisti dovrebbe rimanere una componente chiave degli investimenti sostenibili in futuro.
La sostenibilità è al centro del piano di ripresa per la maggior parte dei governi. Con i piani per ridurre le diseguaglianze sociali e investire in energie rinnovabili su larga scala, trasporti puliti, cibo sostenibile e accorciare e diversificare le catene di approvvigionamento globali, questo probabilmente sosterrà gli investimenti in corso sulle industrie sostenibili. Anche nelle politiche dell’Unione Europea, nel periodo post Covid tali temi stanno avendo un’attenzione molto alta. A tal riguardo si deve parlare del Next Generation EU: un piano per ricostruire l’Europa dopo la pandemia che consiste nello stanziamento di 1.800 miliardi di euro con l’obiettivo dichiarato di renderla più ecologica, digitale e resiliente.
Classificazione degli approcci SRI
Gli Investimenti Sostenibili e Responsabili possono essere declinati secondo varie strategie, ognuna contraddistinta da specifici obiettivi e metodologie, che non si escludono a vicenda e che quindi possono essere applicate allo stesso portafoglio.
Queste strategie, individuate nel 2012 dal Forum Europeo per gli Investimenti Sostenibili e Responsabili (European Sustainable Investment Forum, EUROSIF) sono sette:
1. Esclusione di titoli dall’universo investibile: questa strategia che è senza dubbio quella più datata anche se ancora oggi molto diffusa, consiste nell’esclusione di titoli o di settori dall’universo investibile sulla base di valori etici, principi o criteri stabiliti dall’investitore finale (asset owner) o dal gestore (asset manager). Tra i criteri più utilizzati ci sono le armi, la pornografia, il tabacco e i test su animali.
Tali criteri sono naturalmente soggettivi e dipendono dalla politica di investimento: può quindi capitare che un settore sia sostenibile per un investitore o gestore e non lo sia per un altro. A tal riguardo, i settori dove si registra più difformità di valutazione sono ad esempio l’energia nucleare e la sperimentazione sugli animali.
2. Integrazione di fattori ESG nell’analisi finanziaria: si tratta di una strategia basata sull’inclusione esplicita e sistematica di fattori ESG di rischio o di opportunità nell’analisi finanziaria tradizionale. Nel processo generale di investimento vi è dunque una considerazione dichiarata di questioni ESG oltre che, naturalmente, di quelle tipicamente finanziarie.
Dunque, per quanto riguarda l’ambiente, lo stock picking (scelta dei titoli) delle aziende si concentra sulle aziende sensibili, tra le altre cose, ai processi di riduzione delle emissioni e di CO2, attente all’impatto ambientale dei loro processi produttivi, all’uso delle energie rinnovabili e al corretto smaltimento dei rifiuti. In ambito sociale, si prediligono le aziende che rispettano i diritti dei lavoratori, la tutela della salute, l’impegno a favore dell’inclusione e delle categorie svantaggiate. Vengono inoltre valutate positivamente le aziende attente alla formazione professionale e che guardano al benessere del dipendente con piani di welfare. Per quanto riguarda la governance, infine, sono tenuti in considerazione fattori quali la trasparenza amministrativa, le politiche di remunerazione del management, l’assenza di episodi di corruzione.
A tal proposito può essere rilevante considerare, solo per rimanere a casi di cronaca recenti, il grave danno prima d’immagine e reputazionale, e poi economico-finanziario, che ha coinvolto Facebook in merito ai dati personali di milioni di utenti ceduti alla società Cambridge Analytica: danno che ha avuto notevoli ripercussioni sull’andamento del titolo in borsa.
L’integrazione sistematica dei criteri ESG nella classica analisi di tipo finanziario, se condotta in modo serio e rigoroso, necessita di nuove e diverse informazioni riguardo la vita delle aziende e di nuove competenze in ambito di valutazione aziendale. Tali competenze possono essere implementate o essere acquistate da società terze (ad esempio, dalle agenzie di rating ESG): in ogni caso è un percorso che necessita di investimenti intellettuali e finanziari spesso non indifferenti. L’attenzione che l’investitore deve porre nelle proprie scelte d’investimento deve essere tesa a verificare che l’integrazione di fattori ESG, se fatta in modo non rigoroso, non risulti solo un’operazione di facciata e quindi di marketing per conferire un ‘aspetto’ sostenibile a un prodotto standardizzato (greenwashing).
3. Selezione basata su standard: mediante tale strategia la selezione dei titoli avviene nel rispetto di regole o standard internazionali (per esempio quelle definite in sede OCSE, ONU o agenzie ONU tra cui ILO, UNEP, UNICEF, UNHCR, Global Compact). Di questa categoria fanno parte non solo approcci di esclusione ex ante basati su norme concernenti tematiche ESG, ma anche sovra/sottopesatura di titoli o engagement.
4. Selezione Best in Class: a differenza della strategia di esclusione, in cui l’investitore non considera alcuni settori controversi nella costruzione del portafoglio, nella strategia Best in Class gli investitori scelgono le aziende virtuose in ogni settore economico, valutando quindi anche le aziende che appartengono a settori controversi ma che hanno intrapreso un percorso per arrivare a buone pratiche ESG. Attraverso tale strategia gli investitori selezionano titoli di emittenti relativamente migliori nel proprio settore sulle questioni ESG. Questa categoria comprende l’investimento in società che si distinguono per l’eccellenza sul piano delle performance sia ESG sia finanziarie, all’interno di un dato universo investibile.
Per esempio, un investitore, invece di escludere il settore dei combustibili fossili, può decidere di esaminare le imprese attive in tale ambito e scegliere di investire in quelle più attente agli aspetti di sostenibilità, con progetti di riconversione in ottica di transizione energetica. Lo scopo di questa strategia, oltre ad avere un potenziale di investimento più ampio, è quello di entrare nel settore per cercare, attraverso il dialogo con l’azienda, di indurla a comportamenti più sostenibili.
5. Investimenti tematici: questa strategia consiste nell’investire in società che hanno come missione la promozione dello sviluppo sostenibile. Si selezionano quelle imprese che contribuiscono intrinsecamente alla soluzione di sfide ambientali o sociali, non si tratta quindi di un semplice approccio settoriale.
6. Engagement e azionariato attivo: si tratta di una strategia mediante la quale gli azionisti si impegnano in un dialogo strutturato e costante con il management della società in cui si investe. Nell’ambito di tale strategia si deve differenziare tra soft engagement e hard engagement. Gli scopi di entrambe le attività sono molteplici: da una più corretta politica di remunerazione degli amministratori alla richiesta di più approfondite informazioni ad esempio sui rischi ambientali, ma in genere si può dire che attengono alla sfera della responsabilità sociale d’impresa.
Si parla di soft engagement quando l’azione degli investitori si limita al dialogo con l’azienda.
La strategia di hard engagement invece rientra nell’attività di azionariato attivo e vede gli investitori attivarsi nella promozione di pratiche socialmente responsabili, attraverso l’utilizzo dei diritti derivanti dal possesso di titoli di capitale di un’impresa. In particolare, tale attività si traduce sia in votazioni sui singoli temi all’ordine del giorno in ottica di responsabilità sociale, sia in richieste di integrazione dell’ordine del giorno delle assemblee per poter successivamente esprimere il voto. Nel dialogo con l’investitore o in assemblea, l’emittente può decidere di accogliere e/o assecondare le richieste pervenutegli oppure rifiutarle. Tale rifiuto però può avere conseguenze notevoli anche in termini di prezzo dell’azione. Il processo si può infatti concludere con il disinvestimento del fondo dall’emittente (exit) e con il pubblico dissenso (advocacy), nel quale il fondo oltre a disinvestire esprime pubblicamente il proprio dissenso.
7. Investimento di impatto: con tale strategia si decide di effettuare investimenti progettati specificatamente per generare un impatto socio-ambientale positivo e misurabile, mantenendo un potenziale ritorno finanziario positivo. Si tratta di una modalità d’investimento relativamente nuova: non sono donazioni filantropiche, perché comunque il capitale rimane in capo all’investitore ed è atteso anche un qualche ritorno finanziario, tuttavia, l’obiettivo principale dell’operazione è il ritorno ambientale o sociale. Le caratteristiche salienti di questa strategia di investimento sono: l’intenzionalità dell’investitore di generare un impatto positivo dal punto di vista sociale e ambientale; il rendimento finanziario atteso, che può variare in funzione degli obiettivi dell’investitore ma, in ogni caso, deve prevedere almeno il rientro del capitale investito; l’eterogeneità dei rendimenti, che possono essere inferiori oppure in linea con quelli di mercato, e delle classi di attivo; la misurabilità dell’impatto sociale e ambientale (con diversi obiettivi e metodologie) e la rendicontazione degli impatti generati attraverso la pubblicazione di una reportistica dedicata (report d’impatto).
Il mercato degli investimenti ad impatto fornisce i capitali per affrontare le sfide più urgenti del pianeta in settori come l’agricoltura sostenibile, le energie rinnovabili, l’assistenza sanitaria, l’istruzione. Appare evidente che molti di questi obiettivi coincidono con i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’ONU e si può quindi affermare che proprio questi ultimi obiettivi sono il punto di riferimento per gli investimenti ad impatto.
Gli strumenti finanziari dell’impact investing
Nell’ambito delle strategie SRI un ruolo sempre più importante è rivestito dall’impact investing. Anche se non rappresenta la strategia più diffusa, l’impact investing presenta uno dei tassi di crescita più elevati: tra il 2014 e il 2016 il tasso di crescita è stato pari al 385% e tra il 2016 e il 2018 il tasso di crescita è stato pari al 79%.
Gli strumenti che consentono di investire con l’intento di generare un alto impatto sociale e ambientale si distinguono per:
• tipologia di finanziamento erogato: azionario od obbligazionario o misto;
• tipologia di soggetti finanziati: imprese quotate o non, investimenti in intermediari o diretti.
Gli strumenti finanziari più comuni sul mercato sono:
• Green bond;
• Social bond;
• Social Impact Bond;
• Fondi d’investimento;
• Crowdfunding.
Le dinamiche del mercato degli SRI
Il mercato degli investimenti sostenibili e responsabili sta registrando di anno in anno una crescita significativa a livello mondiale, europeo e italiano. A certificare un contagio virtuoso per gli investimenti sostenibili e responsabili è il rapporto biennale della Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), che riunisce le organizzazioni specializzate in finanza sostenibile di tutto il mondo. I dati relativi al rapporto Global Sustainable Investment Review 2018, l’ultimo ad essere elaborato, evidenziano infatti un ammontare complessivo di 30,7 trilioni di dollari di investimenti sostenibili nei cinque principali mercati: Europa, Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia/Nuova Zelanda. Spicca soprattutto la crescita del 34% rispetto all’edizione precedente del documento (2016), quando la massa di investimenti sostenibili e responsabili si fermava a 22,9 trilioni di dollari.
La quota di mercato della finanza sostenibile cresce quasi in tutti i Paesi e gli investimenti responsabili ora riguardano una quota considerevole della finanza gestita professionalmente. La finanza sostenibile pesa il 18% in Giappone, il 50% in Canada, il 63% in Australia/Nuova Zelanda. L’Europa guida la classifica per valore degli asset sostenibili e responsabili gestiti con 14 trilioni di dollari, seguita a breve distanza dagli USA (12 trilioni). Ampi margini di crescita rimangono invece a Giappone (2,18 trilioni), Canada (1,69 trilioni) e Australia/Nuova Zelanda (734 miliardi).
Con riferimento alle strategie di investimento più diffuse, il primato appartiene alle strategie di esclusione (US$19.800 miliardi). Esse sono seguite dalle strategie di integrazione di parametri ESG (US$17.500 miliardi) e dalle strategie di engagement (US$9.800 miliardi). Da un confronto con i dati della precedente edizione, le strategie che crescono più rapidamente sono investimenti tematici (CAGR +92%) e le strategie best-in-class (CAGR +50%). Per quanto rappresenti ancora una quota ridotta di mercato, l’impact investing segna un aumento del 34% su base annuale e si attesta a US$ 444,3 miliardi.
Guardando in particolare alla situazione europea, a fronte di un incremento dei valori assoluti di patrimonio gestito in modo responsabile (+11% tra 2016 e 2018) per un totale di 14.075 miliardi di dollari (12.300 miliardi di euro), si assiste a una leggera flessione nelle quote di mercato: dal 53% al 49% del totale degli attivi gestiti in modo professionale. Un calo che il rapporto ipotizza possa essere dovuto a un «passaggio a norme e definizioni rigorose». Sul piano delle strategie adottate per applicare la sostenibilità, a dominare rimangono i criteri di esclusione che presiedono alla gestione di 9.500 miliardi di euro.
Conclusioni finali
La performance degli Investimenti Socialmente Responsabili è stata ed è ancora oggetto di discussione tra gli studiosi di tutto il mondo. Il dubbio che la performance sia influenzata negativamente dalla particolare attenzione ai temi ambientali, sociali e di governo societario da parte dei fondi sostenibili, è un argomento molto attuale. In letteratura ci sono al riguardo numerose teorie discordanti: alcune associano ai fondi sostenibili un rendimento medio inferiore rispetto a quello che caratterizza i fondi tradizionali; altre, invece, dimostrano l’opposto, ovvero dimostrano una correlazione positiva tra condotta responsabile e performance economico-finanziaria.
In questo elaborato, l’attenzione è stata rivolta all’impatto che la crisi causata dalla pandemia di COVID-19 ha avuto sui fondi di investimento sostenibili e su quelli tradizionali.
L’emergenza sanitaria in atto ha posto in luce tutte le croniche debolezze del sistema sociale. La pandemia ci ha ricordato che le calamità naturali possono verificarsi in qualsiasi momento e che siamo più vulnerabili di quanto avremmo potuto pensare. In generale, la dolorosa esperienza di questo momento invita a riflettere su tante tematiche di attualità: oltre alle questioni legate all’ambiente e al riscaldamento globale, le decisioni delle imprese che riguardano i propri dipendenti, in particolare facendo riferimento alla salute e alla protezione sociale dei lavoratori nonché alle politiche di smartworking o di contrasto alla disoccupazione, hanno assunto crescente rilevanza. In questo contesto è praticamente impensabile sostenere che gli investitori non debbano tenere conto nelle decisioni di investimento degli impatti ambientali e sociali delle attività delle aziende.
Pertanto, un approccio alla finanza socialmente responsabile assume un’importanza sempre più considerevole.
Infatti, in un periodo caratterizzato da forte crisi ed elevata volatilità, i fondi sostenibili si sono dimostrati in grado di gestire meglio il rischio e di ottenere rendimenti superiori rispetto a quelli tradizionali. Grazie a ciò, sempre più investitori si stanno convincendo del fatto che non esiste alcun tipo di penalizzazione quando si sceglie questo tipo di strumenti: lo dimostrano i dati relativi ai flussi annuali, i quali hanno raggiunto livelli record anche grazie a un aumento dell’offerta.
In conclusione, durante la fase di recessione, i fondi socialmente responsabili si sono rilevati più resilienti se messi a confronto con quelli tradizionali. Pertanto, integrare in maniera efficace i fattori ESG nel processo d’investimento, può migliorare i rendimenti aggiustati per il rischio.
L’auspicio è che ciò consenta al trend che si sta osservando, relativamente all’elevata attenzione alle tematiche ESG, di continuare ad essere una priorità per gli investitori nonostante i problemi economici e finanziari che dovranno essere affrontati nei prossimi anni, in modo da ottenere segni chiari e concreti di un impatto sociale ed ambientale positivo. A tal riguardo sarà importantissimo per gli investitori instaurare un solido e attivo dialogo con le aziende e i governi per richiedere maggiore trasparenza e politiche più sostenibili. →